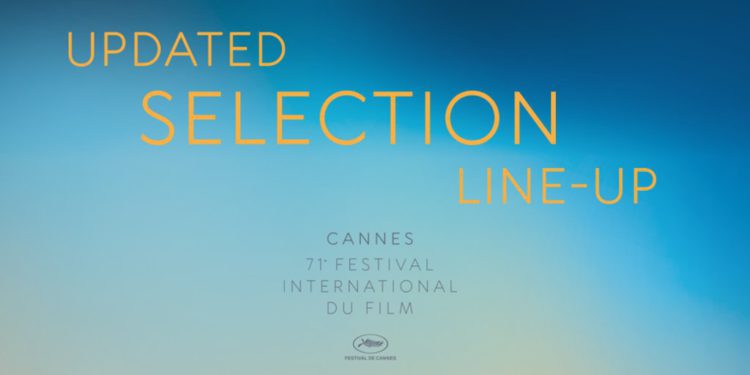
In un’edizione che alla vigilia poteva sembrare “di passaggio”, con pochi nomi di maestri del cinema riconoscibili, consacrati e popolari, contrariamente ad altri anni in cui nel concorso ed in altre sezioni di registi star e attori di fama mondiale ce n’erano almeno uno al giorno, la Croisette è riuscita a ribaltare la prima impressione, presentando molti film di altissima qualità anche se privi di grandi firme.
Un bel messaggio, dunque, quello che lancia Cannes numero 71: c’è un cinema tutto da scoprire, almeno per il grande pubblico, e ora il festival spinge il mercato a fare la sua parte, portarlo nelle sale.
E un senso di gradevole stupore arriva anche dal verdetto della giuria: non ha vinto una donna! Nell’anno in cui tutti pronosticavano una Palma d’oro al femminile – andata al bel film giapponese Un affare di famiglia, di Hirokazu Kore’eda – la giuria presieduta da una donna, l’attrice Cate Blanchett, un caso raro, e con una maggioranza di donne, 5 su 9, ancora una rarità, ha voluto sfuggire a questo imperativo dettato dai tempi che corrono, dalle circostanze. E dire che almeno 2 su 3 film in concorso firmati da registe, l’italiano Lazzaro Felice, di Alice Rohrwacher, al quale è andato il premio per la sceneggiatura, e il libanese Capharnaum, di Nadine Labaki, premio della giuria, potevano meritare il massimo riconoscimento. Dalla parte della donna con l’alloro del primo premio c’era anche la cruda statistica: è da 25 anni che una donna non vince il festival di Cannes, accadde a Jane Campion con Lezioni di piano.
E allora dalla Croisette un altro messaggio di grande significato: le donne vogliono essere riconosciute per il loro valore, e non in quanto donne, per categoria e per “quote”. Giacché, per paradosso, forse le quote le hanno inventate gli uomini!
Le tracce, i messaggi, appunto, che lascia il festival di Cannes, e quelli che insegue spesso appena preceduto dalle cronache, dalla più vicina attualità, dagli eventi degli anni che viviamo.
Il primo piano, in ogni caso, è andato alle donne, con la nuova visione della figura femminile che si è imposta, ora protagonista e riscattata dopo le coraggiose ancorché tardive denunce degli abusi subiti da produttori e artisti senza scrupoli. La composizione della giuria è comunque un segnale forte, e certo l’auspicio degli organizzatori è stato forse quello che non rimanga, appunto, una rarità mentre si aspetta che venga il giorno in cui la presenza di donne e di uomini in tutte le varie declinazioni che assume la “rappresentanza”, istituzionale, civile, sociale non sia più una “notizia” da titoli dei giornali e materia di cui compiacersi. Una parità, insomma, che non sia solo affidata ai numeri, e che dunque non sia più necessario contare gli uomini e le donne presenti nelle diverse forme di espressione della società.
Un segnale in cui, tuttavia, se guardato con un freddo distacco critico privo di facile e magari mutevole entusiasmo, può anche essere individuato un sospetto di retorica, come una scelta portata dal vento che spira. Ma intanto questo segnale c’è e può diventare punto di partenza, qualcosa che altri possono sentirsi chiamati a emulare. Certo, è stato necessario il caso Weinstein per far venire alla luce lo stato di soggezione che molte donne hanno vissuto nel mondo dello spettacolo, delle arti, della cultura, e non solo.
E Cannes non si è fatta sfuggire l’occasione. E se il festival ne avesse fatto anche un calcolo di immagine, se ci fosse della retorica, il valore della scelta resta. Anche se qualche retropensiero è legittimo. Perché forse sulla Croisette si è voluto strafare. Il festival, infatti, ha istituito un numero verde e lo ha fornito con il resto del materiale stampa a tutti i giornalisti e festivalieri vari, per la denuncia di abusi da parte delle donne durante la manifestazione. Un’iniziativa che in molti, tante donne comprese, ha suscitato amare ironie. Troppa grazia, insomma.
Poco male anche il numero esiguo di registe in concorso, 3 su 21 pellicole. Ma noi scegliamo i film che più ci colpiscono, e non gli autori donne o uomini, ha detto il direttore di Cannes, Thierry Fremaux. Un’affermazione che vien fatto di definire rivoluzionaria, perché, consapevolmente o meno, anticipa quel che dovrebbe essere e che forse un giorno sarà in tutti gli ambiti della società, la parità come fatto acquisito, senza doverla rivendicare, senza senza obblighi di legge in favore delle donne, o chissà un giorno, a vantaggio degli uomini.
Sulla Croisette anche le minacce palesi o striscianti che incombono sulla libertà di pensiero. Qui siamo nei territori del cinema, ma in ogni angolo del pianeta non c’è forma di espressione, dalla letteratura al giornalismo, che non sia in qualche modo sotto tiro.
E così nel cartellone due film con registi fantasma, assenti forzati, detenuti nei rispettivi paesi. Il russo Kirill Serebbrennikov con Leto (Estate), che è agli arresti domiciliari dall’agosto scorso. La magistratura del suo paese lo accusa di distrazione di fondi pubblici; Serebbrennikov si sarebbe appropriato di risorse destinate al teatro Gogol di cui è direttore. Ma il motivo viene ritenuto pretestuoso: il regista è infatti un dissidente e i suoi spettacoli molto critici nei confronti del potere non sono graditi. Ora vive da sorvegliato speciale e non può lasciare il paese. A Cannes sulla scalinata più famosa del mondo che introduce al palazzo del cinema, alcuni attori hanno mostrato un cartello col nome del regista, immagini ritrasmesse in tutto il mondo; e in sala è stata lasciata una poltrona vuota, riservata a Serebbrennikov. A nulla sono valsi gli appelli lanciati da Cannes in suo favore, compresa una lettera ufficiale della Francia alle autorità del suo paese. E Putin ha risposto con un orgoglio apparso anche sprezzante: in Russia la magistratura è indipendente. In Russia. In filigrana nel suo film ambientato ai tempi dell’Unione Sovietica quando i giovani cercavano un po’ di libertà attraverso il rock che arrivava dall’occidente, non è difficile cogliere spunti autobiografici e dell’attualità politica del Paese.
Stessa sorte per il regista iraniano Jafar Panahi in concorso con il film 3 faces, premio ex aequo per la sceneggiatura. Il cineasta, autore di film di successo premiati in diversi festival come Il cerchio, Il palloncino bianco, Taxi Teheran, quest’ultimo, girato in clandestinità, Orso d’oro a Berlino 3 anni fa, è agli arresti dal 2010, ed è stato condannato a 20 anni di carcere, accusato con suoi film di posizioni antiregime. Durante la “rivoluzione verde” Panahi si era schierato con chi si batteva per un cambiamento in senso democratico. Ora non può uscire dal suo paese.
Ecco, allora, che in questi casi come in altri, Cannes ha fatto il suo mestiere: territorio libero per definizione, come altri festival in Italia, in Germania e in altri paesi ha lanciato al mondo il suo messaggio per la libertà dell’arte e del pensiero. Difficile che venga raccolto, ma almeno il tentativo è stato fatto.
Scorrendo il programma ecco le guerre striscianti, non dichiarate, spesso dimenticate, come quella del Donbass, portata sullo schermo con un titolo omonimo dal regista ucraino Sergei Loznitsa. In questa regione dell’Ucraina dal 2014 si combattono nazionalisti e ribelli filorussi: violenze indicibili, linciaggi senza pietà, paura, ricatti.
Altre guerre senza fine, in Medio oriente, con il libanese Capharnaum, della Labaki, bambini vittime della cecità e dell’egoismo degli adulti, profughi senza terra, la violenza delle armi.
Ancora la guerra, quella non combattuta, di per sé non cruenta eppure forse altrettanto percorsa da ferocia, quella guerra che per consolarci chiamiamo fredda, nell’importante film polacco Cold War, di Pawel Pawlikovski, ambientato negli anni ’50 tra Polonia, Parigi e mezza Europa, una guerra che oltre alle libertà ghermisce anche i sentimenti tra i più preziosi, un amore che diventa impossibile. A questo film è andato il premio per la regia.
E proprio nei giorni della possibile distensione tra le due Coree, e tra quella del Nord e il resto del mondo, il film sud-coreano Gongiak, di Yoo Jong-bin che rievoca la storia di un ufficiale della Corea del Sud che negli anni ’90 accettò un incarico vicino all’impossibile, infiltrarsi ai vertici del regime nord coreano per tenere sotto controllo l’avanzamento dell’attività nucleare. Anche in quell’epoca, doppi giochi, secondi fini, tradimenti, corruzione, si ebbero gesti di distensione, miseramente falliti, come rischia di accadere oggi tra un passo avanti e due indietro.
La ricerca delle proprie radici e della famiglia perduta, tema che nel nostro tempo emerge con lo sradicamento a cui è costretto chi da continenti senza sviluppo cerca una vita più dignitosa, nel film egiziano Yomeddine, di Abu Bakr Shawky, dove un poverissimo lebbroso guarito percorre mezzo Egitto in groppa a un asino alla ricerca della sua famiglia che lo aveva abbandonato da piccolo. Proprio il valore e il bisogno di famiglia, è il tema portante del film che ha vinto la Palma d’oro, Un affare di famiglia, accanto a una realtà sociale giapponese che poco conosciamo, quella di chi vive ai margini, alla periferia di Tokio, lontana anni luce dal benessere di cui i Paese porta vanto, quella marginalità di chi vive in miseria, in una sopravvivenza affidata agli espedienti. L’essenzialità dei legami familiari si ritrova anche nel film di Valeria Golino Euforia, dove i due fratelli dalle vite e caratteri opposti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea si ritrovano in seguito a una malattia di evidente metafora. La famiglia tema dominante in un altro film, lo spagnolo Todos lo saben, di Asghar Farhadi, in cui Penelope Cruz e suo marito Javier Bardem ritrovano un segreto legame di sangue custodito in un vecchio passato.
E ancora, tra i tanti temi del festival, l’intolleranza e la sopraffazione verso scelte individuali che consideriamo “diverse” nel film del Kenia Amiche, della regista Wanuri Kahiu, dove due ragazze che sentono una castissima attrazione, subiscono un doloroso linciaggio sociale. Il film è proibito nel suo paese.
E poi ancora, il razzismo che di tanto in tanto si riaffaccia anche in Europa come in altri continenti attraverso mille facce con il film sul Ku Klux Klan di Spike Lee, Gran premio speciale della giuria. Ambientato negli anni ’70, c’è grande tensione nello stile tipico del regista, con la sua ironia, il sarcasmo, la sua radicalità. E tuttavia non mancano un paio di riserve: i razzisti ridotti a semplici seppure pericolose macchiette, sprovveduti, ignoranti, in preda a un fanatismo epidermico, isterico, esasperato e ridicolo, e un finale fin troppo didascalico e non necessario, con fatti e personaggi delle cronache dei nostri giorni.
La durezza dei rapporti tra un’imprenditoria senza scrupoli e la classe dei lavoratori, il capitalismo selvaggio globalizzato nel bel film francese En guerre, di Stéphane Brizé.
Il mite personaggio di Dogman, l’ottimo film di Matteo Garrone – il protagonista Marcello Fonte premio come migliore attore – in un ambiente in cui il più forte soggioga sempre il debole in una vita di sopraffazione senza fine dalla quale non c’è uscita, nonostante la ricerca di un riscatto che invece cade nell’indifferenza.
E la bella fiaba contemporanea di Lazzaro Felice, l’opera affascinante di Alice Rohrwacher, con il suo personaggio che tutti sfruttano per la sua bontà assoluta, l’innocenza ineffabile e disarmante, una figura di una semplicità che non è di questo mondo.
E c’è l’ennesimo capolavoro del grande vecchio Jean-Luc Godard che con Le livre d’image consegna il suo testamento; cinema puro fuori dalle convenzioni sui drammi del nostro tempo, le guerre, la spregiudicata morale dei crimini di Stato, lo scontro cruento tra la classe dei ricchi e quella dei poveri. A Godard la giuria, essendo fin troppo facile e scontato fargli vincere il festival, ha attribuito una Palma d’oro speciale.
E non è mancato il film scandalo, come c’era da aspettarsi dal danese Lars von Trier: il delitto come opera d’arte, il crimine più efferato come atto estetico, l’idea che ci possa essere una “grandezza” nel compiere il male, fino in fondo, fino ad una abiezione senza limiti, nel discusso e programmaticamente sgradevole film The house that Jack Built. Un film stroncato dai più, gettato nel cestino, abbandonato durante la proiezione da molti spettatori sconcertati e nauseati, e che tuttavia non lascia indifferenti.
E non ultimo tema, Cannes 2018 ha fatto la scelta, alienandosi le simpatie degli americani che ormai da qualche anno sembrano preferire Venezia, di sbarrare il concorso ai film di Netflix, dopo aver chiesto alla catena televisiva di aprire ai film la strada delle sale. La risposta non si era fatta attendere, con il ritiro dal festival di tutti i film con quel marchio. Nel tempo in cui il cinema dal grande schermo tende ormai a trasferirsi in Tv e agli apparecchi portatili perdendo così la sua essenza, Cannes chissà se per quale calcolo calcolo, per necessità, o per meditata scelta di principio, ha fatto la sua parte.
Ecco, solo alcuni spunti da Cannes 2018, l’impegno politico, sociale, artistico accanto al divismo, allo scintillìo di luci e alla polvere di stelle. Se ci si può anche chiedere legittimamente a cosa “serve” un festival come Cannes, ecco, dunque dalle tematiche e dalla qualità dei film qualche possibile risposta, senza dimenticare una delle sue funzioni, quella di alimentare l’industria del cinema. Come ha detto durante il festival un distributore internazionale: senza Cannes si perdono soldi, con questo festival invece si recuperano gli investimenti e spesso ci si guadagna.
Nino Battaglia